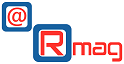Sappiamo solo che iniziava per M. Rendere omaggio alle vittime è innanzitutto dire il loro nome, ma quel nome non c’è. La mamma l’ha sussurrato appena.
Non ho avuto il cuore di chiederle di ripetere il nome della bambina fredda con gli occhi chiusi dentro nascosta da una tenda troppo corta nella clinica di bordo.
Immaginate di dover mettere in valigia un paio di scarpe da ginnastica, immaginate di infilarle in una busta bianca. È grande più o meno così una body bag per il cadavere di una bambina di sei mesi.
Quando lo abbiamo trasbordato sulla motovedetta della Guardia costiera, appena sotto Lampedusa, sembrava di tenere in mano un vassoio vuoto incartato tanto era leggero quel minuscolo pacchetto bianco.
La vedetta di turno sul ponte li ha visti da prua ieri prima dell’alba. Un guscio di alluminio arrugginito, uno di quei barchini tutti uguali fatti in serie in Tunisia. Ore cinque e un quarto del mattino, 17 miglia da Lampedusa, 50 dalla Tunisia.
Se esistesse una missione europea di salvataggio, se ci fosse stata una Mare nostrum dispiegata in mare in questi due maledetti giorni in cui loro vagavano alla deriva, quel barchino (45 persone) e quello che abbiamo soccorso subito dopo (altri 40) sarebbero stati avvistati l’altro ieri o il giorno prima da una nave militare, dalla nostra guardia costiera, da una missione pubblica di salvataggio.
Ora M. sarebbe viva. Invece è stata in mare almeno due notti, non beveva da chissà quanto ed è morta in braccio alla mamma, una ragazza con un piccolo orecchino d’argento e un’altra figlia di 3 anni stretta tra persone tremanti, con i vestiti fradici di benzina, di cacca, di pipì. Con ustioni da carburante e acqua di mare in tutto il corpo, scabbia.
Guinea, Mali, Sierra Leone, Costa d’Avorio, Camerun, vengono da lì. Tutti nel barchino hanno capito che la bambina è morta, la mamma dice “sta male”, qualcuno fa un cenno veloce con il palmo della mano: “is gone”, è andata.
La sorellina sale a bordo per prima, cammina incerta, ha minuscole trecce e gli occhi sbarrati. È zuppa di carburante. La madre è bella. Le sfila con dolcezza i pantaloni incollati ormai alla pelle, chiede di poterla accompagnare in bagno.
La sveste, le lava via la benzina, le avvicina la tutina blu trovata nel kit di salvataggio per misurarla a occhio, controlla che sia di una giusta taglia. La asciuga, le mette le mutandine pulite, i calzini rosa, le scosta i capelli dalla fronte. Poi chiede in francese: “dov’è la mia bebè?”.
In clinica, dove sono i dottori. Lei mi guarda fissa, in silenzio. La bambina trema, nella cabina con i letti a castello per donne e bambini non c’è più posto.
Nel kindergarden ancora deserto ci sono morbidi tappeti neri già pronti a terra, lei distende una grande coperta grigia, avvolge la bambina, le toglie un lembo dal viso, la guarda addormentarsi in silenzio. Dieci lunghi minuti. Alza gli occhi: “where is my baby?”.
Si stanno alzando in piedi tutti, è sorto il sole. Stanno arrivando altri naufraghi, stiamo ancora tirando su i gommoni dall’acqua. Non si può rispondere “in clinica”, a una ragazza che ti chiede dov’è sua figlia, e tu sai che sua figlia è morta.
Glielo dirà il medico, con l’ostetrica, la psicologa. Mentre la bambina di 3 anni dorme sul tappeto e mentre a bordo stanno salendo altre 40 persone, per lei e la sua piccola bambina morta ci sarà un lungo tempo privato, una riservatezza totale, un saluto infinito e indecente in mezzo al mare.
Lampedusa è lì, a un passo. M. ci arriverà verso le 11 su una motovedetta della Guardia costiera, avvolta in un pacchetto chiuso ai bordi come una caramella.
Con 183 persone a bordo, tra cui 102 minori, 76 dei quali non accompagnati, due donne incinte (una è un’adolescente) tirate su dall’acqua nelle ultime 24 ore, la Humanity1 va verso il porto di sbarco assegnato dal Comando delle capitanerie di porto di Roma: Livorno, oltre 920 chilometri lontano da dove è stato fatto l’ultimo salvataggio, altri due giorni di navigazione e cosa importa, in fondo, se ci sono una quarantina di persone che hanno passato le ultime due notte strette intorno al cadavere di una bambina di sei mesi pensando di morire loro.
L’Italia è stata generosa, ha portato via il cadavere di una bambina di sei mesi insieme alla madre e alla sorella senza lasciarla due giorni al caldo in una nave di soccorso privata priva di cella frigorifero. Che vuoi di più. Ospitalità italiana.
Sul ponte di coperta ci sono due minuscoli sandali blu con orsetti, ciabatte rosse numero 42, una tutina con piedini da 6/8 mesi con l’arcobaleno, dietro le docce un gruppo balla, due ragazze mostrano tabacco nero, vogliono fumare, c’è carburante ancora, vogliono fumare, un uomo enorme con berretto di lana rosa guarda Lampedusa da lontano, un ragazzino dà il biberon a una neonata vestita di bianco, una signora sudanese si copre il viso con un incredibile velo amaranto.
Niko, medico, sta sui gommoni a ogni salvataggio scrive un diario personale, prezioso. In tedesco. Questi sono alcuni appunti degli ultimi giorni: “Siamo già in viaggio alla massima velocità nella direzione dell’emergenza. Questa volta in una zona più insolita, che mostra ancora una volta come accadono qui le cose lontano dagli occhi che osservano. Probabilmente non sorprende più nessuno che qualche tempo fa la zona Sar libica sia stata estesa molto a nord. Mi sono aggrappato davanti alla prua del gommone di salvataggio mentre attraversavamo la notte nera profonda. Ancora onde, il vento forte. In una mano tengo il faro mentre ci fermiamo alla piccola luce ondeggiante in mezzo al nulla. L’occhio umano non può stimare la distanza da un singolo punto di luce nella completa oscurità. Improvvisamente il gommone grigio chiaro era davanti a noi. Era pieno di persone, le gambe appese in acqua da uomini seduti a cavalcata sui tubi, mentre la barca si piegava su ogni onda e sbatteva. Questa volta è stato più difficile di stamattina: il vento più forte, le condizioni più difficili, la gente più ansiosa. Mentre la più grande delle nostre due scialuppe di salvataggio cercava di controllare la folla, ci posizionavamo sempre esattamente di fronte all’altra parte del punto di fuga. Tutto ora è come una danza, ogni movimento è inteso. Da un lato, per non attirare tutti i naufraghi su una sponda, dall’altro, per assicurarsi che non ci sia un punto cieco in cui qualcuno possa cadere in acqua e non essere visto. Teniamo sotto controllo il nostro linguaggio del corpo per non creare confusione. Sono in piedi nella prua e ho già un salvagente in mano. Posso lanciarlo in modo mirato con il vento? Improbabile”.
“Ascolto le due radio sul mio giubbotto di salvataggio, illumino la scena dalla mia parte, giudico con la persona alla guida del nostro gommone la disposizione in continua evoluzione delle nostre barche, cerco allo stesso tempo di avere la distanza e la direzione dalla nave madre e dalla petroliera sullo schermo, di tanto in tanto scannerizzo il cielo alla ricerca di droni. Dopo tutto, questa volta posso risparmiarmi di cercare la cosiddetta guardia costiera libica”.
“Cosa sento? Niente. C’è troppo da fare, non mi sento nemmeno molto stressato – o è diventata una routine finora o è semplicemente troppo da sentire. Durante le ultime missioni, ho sempre cercato di prepararmi mentalmente per il caso peggiore, il Mass Person Over Board Scenario, in cui c’è un numero incontrollabilmente grande di persone nell’acqua. I colleghi della medicina d’urgenza lo sanno: in realtà, nella nostra società umanistica, cerchiamo di salvare ogni singola vita; lasciare morire uno per salvare l’altro è fuori questione. È diverso quando le risorse sono limitate, per esempio con due piccole scialuppe di salvataggio e diverse decine di persone in acqua. Allora si applica “il meglio per la maggior parte” – un approccio in cui si dovrebbe salvare prima coloro che hanno le migliori possibilità. In un caso del genere, sarebbe il mio compito decidere chi cercare di salvare per primo e chi no. Ancora e ancora una volta ho mostrato i criteri: chi ha un giubbotto di salvataggio viene per ultimo. Se sei in silenzio, probabilmente sei già impotente – non c’è tempo per il primo soccorso – quindi passa, salva quello che sta ancora urlando e schizzando. O il contrario? Coloro che sono appena diventati silenziosi potrebbero avere un’altra possibilità. Colui che sta ancora annaspando ha abbastanza forza per i prossimi due minuti?”.
“Mi fermo sulle scale, alcuni giovani si godono la vista. Sono contento che possano ancora riconoscere la bellezza del mare e trovare la pace in esso. Mi parlano della loro fuga. Sto mescolando le loro storie, sto cambiando tutti i nomi per renderli irriconoscibili. Uno di loro viene dalla Nigeria. Lì è fuggito qualche anno fa perché una milizia stava facendo purghe, così si chiamano, voleva sradicare tutte le persone della sua etnia. Suo fratello è morto così. Lui è fuggito per sostenere da lontano sua madre e sua sorella, dice che le ha lasciate in relativa sicurezza. Per attraversare il Sahara è stato portato in una jeep. Quando non andavano più avanti, hanno dovuto camminare, un piccolo trekking. Chi non poteva più, chi cadeva, doveva rimanere sdraiato, dice. Si sono aiutati a vicenda condividendo la loro urina per bere.
Un altro racconta come è stato in Libia. Ogni volta, in ogni missione di salvataggio, i sopravvissuti a bordo concordano sul fatto che è l’inferno peggiore è in Libia. I neri sono trattati peggio del bestiame, riferiscono, lavorano per un po’ di pane bianco la sera. Chi chiede soldi per il lavoro rischia la vita. Molti lavorano per anni nella schiavitù moderna senza stipendio fino a quando non hanno lavorato il tempo per una traversata. La morte arbitraria minaccia ovunque, e nessuno è interessato alla vita di un nero. In mezzo al silenzio, sguardi che vagano in lontananza, i volti diventano duri, la stessa espressione più e più volte. In questo silenzio trovo l’orrore della Libia. Devo stare attento a me stesso per non dire cose ridicole”.
“T., che ha la mia stessa età mi dice che ci sono state molte ore in mare in cui tutti si chiedevano se mai avrebbero visto qualcuno all’orizzonte e soprattutto chi. Dice che avrebbe preferito morire piuttosto che essere riportato dalla cosiddetta guardia costiera libica. Queste persone hanno sperimentato questo. E vogliamo impedire loro di venire da noi. Quanto devono essere alte le recinzioni per fermare T., che ha già preso questa decisione? Quanto dobbiamo rendere disumano il nostro sistema per spaventare così tanto i migranti? Sono sicuro che la logica delle recinzioni sta raggiungendo i suoi limiti qui in questo bel mare. Chi vuole attraversare un confine recintato, lo farà comunque. Devi sparare a queste persone, altrimenti non si lasceranno fermare. Ci siamo quasi: quello che succede qui nel Mediterraneo è uccidere per omissione. Solo che è un lavoro pulito e silenzioso, e quasi nessuno deve toccare una pistola”.