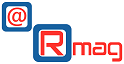Era il gennaio 2022. Giuseppe, detenuto nel carcere di Milano Opera, cade nella propria cella e viene ricoverato di urgenza in stato di incoscienza. L’esito è un “trauma cranico con ecchimosi periorbitale destra e contusione periorbitale sinistra e una frattura delle ossa nasali”. Non è la prima volta che succede. Giuseppe è affetto dal morbo di Parkinson, oltre a tante altre patologie che rendono la sua vita detentiva una costante sofferenza e comportano la necessità dell’affidamento completo alla pietà e al buon cuore del suo compagno di cella, Giovanni, che ne ha cura, lo lava, lo veste, si occupa di lui in tutte le necessità del quotidiano, anche nei bisogni fisiologici, come un infante.
Giuseppe partecipa ai laboratori di Nessuno Tocchi Caino. Arriva in sedia a rotelle spinto dal suo compagno e sta in prima fila, alla destra del palco del teatro intitolato a Marco Pannella. Parla con molta fatica e risulta pressoché inintelligibile quel che dice. Ma è lì, ascolta, finché ne ha la forza. Poi il suo compagno lo riaccompagna in cella. È detenuto dal 1990, Giuseppe, ininterrottamente, con una condanna all’ergastolo per gravissimi fatti di reato e un carattere ruvido e ombroso. Le relazioni di sintesi, poche e prodotte a distanza di molti anni le une dalle altre, parlano di un comportamento a volte oppositivo e discontinuo. Certo non è facile la vita di relazione per chi soffre la prigione del proprio corpo malato oltre a quella della reclusione. Eppure un giorno, ormai di molti anni fa, Giuseppe è stato protagonista insieme ad Antonio Aparo, anche lui ristretto a Opera, che lo ha raccontato, di un luminoso miracolo di riconciliazione.
Antonio e Giuseppe erano contrapposti in una faida di morte ormai trentacinque anni fa. Antonio aveva vissuto lunghi anni al 41 bis e aveva saputo superare l’orrore della sua storia passata ma nel suo cuore batteva ancora un sentimento di vendetta per quell’uomo, Giuseppe, che aveva tolto la vita a suo fratello. Fuori dal baratro del 41 bis, però, se lo era visto davanti nel carcere di Voghera, malato e tremante, sconfitto, come lui, dai propri terribili sbagli e si erano ritrovati fratelli, figli della stessa caduta e ormai non più nemici, ad abbracciarsi. Un gesto meraviglioso di riparazione, di riconoscimento nell’ altro di sé stessi. “Antonio, Antonio, sei tu?”. Aveva detto Giuseppe nel vederlo. Una invocazione di amore e di reciproco perdono di due uomini compagni nella atroce condizione del delitto e ora del dolore della pena e nel superamento del male del lontano passato.
Ormai però la detenzione per Giuseppe era solo afflizione, sconforto, mutilazione di dignità. Non poteva aspirare a recuperare una dimensione di vita libera e produttiva, a riabilitare, a reinserire. Serviva solo a resistere alla malattia, confidando nell’aiuto degli altri ristretti per l’igiene, il controllo, l’alimentazione, la vita stessa, senza il conforto dei propri cari, temendo l’esito della successiva rovinosa perdita di equilibrio che per un uomo malato, non deambulante, sovrappeso e assai spesso non padrone del proprio corpo poteva risultare letale. Inutile l’istanza del difensore rivolta al tribunale di sorveglianza per permettergli di tornare a casa, in detenzione domiciliare. È ancora pericoloso, si legge nel provvedimento di rigetto, e le sue condizioni di salute sono adeguatamente curate in carcere anche col ricorso ai presidi esterni. Giuseppe resta così recluso, a espiare una pena inutile e ormai solo punitiva e afflittiva finché arriva la notizia di quell’ultima quanto prevedibile caduta che ha spento i suoi giorni e consumato le sue ultime ore di solitudine, nella assenza del calore e delle carezze dei propri affetti, nel silenzio di una cella. Una pena nella pena.
*Avvocato, Consiglio Direttivo di Nessuno tocchi Caino