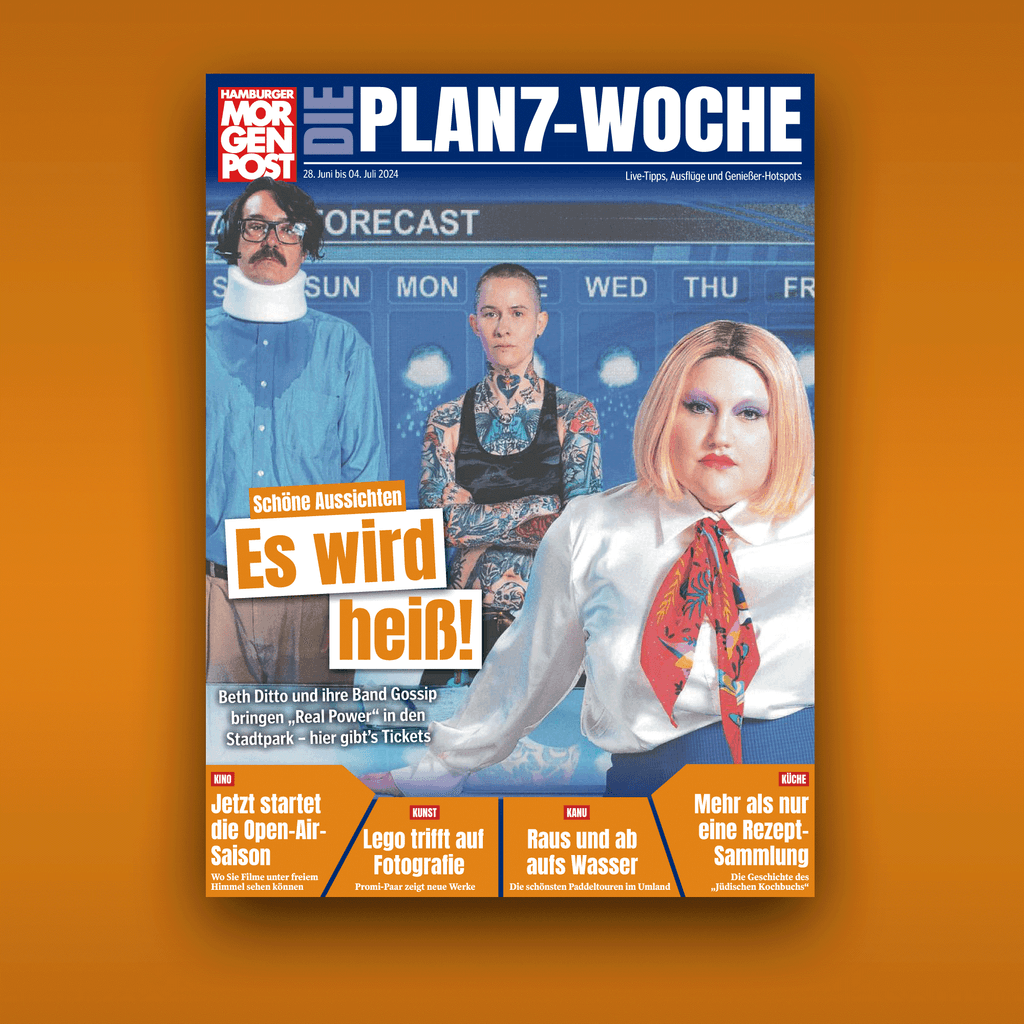È molto difficile riassumere in un articolo la vita e le traversie giudiziarie di Julian Assange, 53enne hacker australiano, passato alla storia per aver pubblicato on line documenti che mettevano in cattiva luce l’amministrazione degli Stati Uniti. Mosso, come ha sempre dichiarato, da un ideale di giustizia, Assange nel 2006 fonda WikiLeaks. L’obiettivo era quello di pubblicare documenti riservati e rivelare così a tutti i segreti del Paese più potente del mondo. Grazie ai file trafugati da Chelsea Manning, all’epoca un ex soldato dell’esercito americano, nel 2010 WikiLeaks svela per la prima volta i crimini di guerra commessi dall’esercito statunitense dopo la guerra del Vietnam. Si tratta in particolare di 70.000 file relativi al conflitto in Afghanistan e 400.000 relativi a quello in Iraq. A questi valanga di documenti si aggiungono ben 250.000 cablo diplomatici americani contenenti anche rivelazioni imbarazzanti sullo spionaggio effettuato dagli Stati Uniti nei confronti di Paesi e leader alleati.
A novembre di quell’anno la magistratura svedese lo accusa di aggressione sessuale e stupro sulla base delle denuncia di due donne con cui Assange aveva avuto inizialmente rapporti consensuali. Accuse controverse che creano però un precedente giudiziario nei suoi confronti in vista dell’avvio della richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti. Le accuse, comunque, cadranno negli anni successivi e la stessa Procura di Stoccolma chiederà poi l’archiviazione del fascicolo. A dicembre del 2010, trovandosi a Londra, Assange viene fermato dalla polizia britannica su richiesta della Svezia e posto ai domiciliari. Convintosi che sia una messinscena per una sua successiva consegna agli Usa, l’attivista decide a sorpresa di rifugiarsi nell’ambasciata dell’Ecuador nel Regno Unito, sotto la protezione dell’allora presidente Rafael Correa. Per circa 7 anni Assange vivrà quindi in una stanza dell’ambasciata insieme al suo gatto e le immagini della “autoreclusione” diventeranno virali.
A maggio 2019 il governo dell’Ecuador decide di porre fine alla tutela diplomatica e Assange viene subito arrestato da Scotland Yard e portato nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh. Rimarrà in cella anche se le accuse, come detto, erano cadute poiché nel frattempo era arrivata la domanda d’estradizione degli Usa. Inizialmente gli viene contestata la pirateria informatica. Poi, a novembre, si aggiungono altri 17 capi d’imputazione ben più gravi in base allo Espionage Act, una legge del 1917 mai invocata prima per un caso di pubblicazione mediatica di documenti segreti e che prevede in caso di condanna una pena fino a 175 anni di reclusione. Una delegazione dell’Onu per i diritti umani lo visita a fine 2019. Assange denuncia i sintomi di una tortura psicologica per le pesanti condizioni detentive. Associazioni per i diritti umani e la tutela dei giornalisti come Amnesty International o Reporter Senza Frontiere decidono di prendere posizione sul caso, unendosi alla mobilitazione promossa nel mondo da WikiLeaks e denunciando l’inchiesta come una minaccia alla libertà d’informazione. Vari medici iniziano anche a lanciare allarmi sulla salute fisica e psichica di Assange che viene colpito da un principio d’ictus. In prigione si sposa con Stella Morris, avvocata sudafricana, che gli aveva dato due figli negli anni trascorsi nell’ambasciata dell’Ecuador.
All’inizio del 2021, a seguito di una sua istanza, la giustizia britannica nega la consegna agli Usa, dando ragione alla difesa solo sul timore di un rischio di suicidio negli Usa. A dicembre dello stesso anno l’Alta Corte di Londra cambia idea e concede il nulla osta, già autorizzato a suo tempo dall’allora ministro dell’Interno britannico, confidando sulle rassicurazioni di Washington sul futuro trattamento processuale. A marzo dell’anno successivo la Corte Suprema rigetta ulteriori ricorsi che erano stati presentati e consente a un giudice della corte di Westminster di formalizzare l’ordine esecutivo di estradizione. Gli avvocati di Assange, a luglio del 2022, decidono però di presentare un nuovo appello. Cinque grandi giornali che avevano collaborato con WikiLeaks (New York Times, Guardian, El Pais, Le Monde e Der Spiegel) lanciano allora un appello all’amministrazione Biden per far cadere le imputazioni. Richiesta a cui si unisce il governo dell’Australia. E si arriva quindi al 2024. Lo scorso febbraio l’Alta Corte di Londra autorizza l’esame dell’ulteriore appello chiesto dalla difesa, nel timore che Assange non possa invocare il primo emendamento della Costituzione americana sulla tutela della libertà di espressione – non essendo cittadino statunitense – e quindi avere un giusto processo. Le settimane passano e dagli Usa arrivano le prime aperture in risposta alle pressioni australiane, con la disponibilità dichiarata di Biden a valutarle, anche con un possibile patteggiamento.
Lunedì scorso, dunque, il tanto atteso accordo vede la luce. Assange accetta di riconoscersi colpevole di un solo capo d’accusa su 18 e le autorità Usa di ridurre la pena agli anni già scontati in carcerazione preventiva in Gran Bretagna. Julian viene scarcerato e parte ieri per l’Australia, dopo la convalida del patteggiamento davanti a un giudice americano in uno scalo alle Isole Marianne. Si chiude dunque una odissea giudiziaria senza precedenti. Il patteggiamento consente all’amministrazione Biden di liberarsi di un caso quanto mai imbarazzante di fronte ad ampi settori dell’opinione pubblica internazionale, a pochi mesi dalla sfida presidenziale con Donald Trump. L’ex numero due di quest’ultimo, il vicepresidente Mike Pence, ha invece criticato quanto accaduto, definendolo un “errore giudiziario” che “disonora il servizio e il sacrificio degli uomini e delle donne delle nostre forze armate”. “Non commento. Non sappiamo di cosa si tratta, di che tipo di accordo è, se ce n’è stato uno: aspettiamo informazioni più dettagliate, se mai saranno disponibili”, ha detto invece il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Unanime la soddisfazione da parte del mondo politico italiano per l’esito della vicenda.